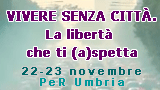Francesco Fantuzzi è uno dei responsabili della cooperativa finanziaria etica Mag 6 di Reggio Emilia, che da oltre 30 anni è fra i progetti più interessanti in Italia per quello che riguarda la costruzione di una comunità diversa dai parametri del sistema attuale, che concepisce solo lo sfruttamento di persone e ambiente per raggiungere più potere e profitto possibile.
Ma Fantuzzi non si occupa solo di finanza etica; esplora anche altri campi come dimostra nel suo ultimo libro, La società dell’emergenza, edito dalla casa editrice Sensibili alle foglie.
La sua è una analisi efficace e puntuale di quello che è l’ossimoro dell’emergenza permanente, che permette a qualsiasi sistema autoritario, a maggior ragione se mascherato da finta democrazia come lo sono genericamente i paesi occidentali, di imporre misure che altrimenti sarebbero difficili da digerire. L’esempio più lampante è quello della faccenda Covid dove sono state calpestate tutte le libertà e la basilari regole democratiche ed è stata instaurata l’apartheid per i dissidenti con la scusa del “terribile” virus.
Nella società dell’emergenza i media hanno un ruolo fondamentale dato che senza il loro terrore quotidiano non si potrebbero produrre né emergenze nè tantomeno riuscirebbero a vendere copie o pubblicità nei propri palinsesti. L’emergenza permanente poi fa preferire uomini e donne forti che con pugno di ferro fanno piazza pulita di dubbi, domande, opinioni perché di fronte al (finto) pericolo c’è poco da questionare, bisogna credere, obbedire e possibilmente combattere. C’è un'emergenza per ogni evenienza che viene accesa o spenta a seconda del bisogno, che si tratti di terrorismo islamico, talebani, immigrati, virus, Cina, Russia, marziani, venusiani e varia. E da questo punto di vista l’ultima emergenza della serie, identificata nella russofobia, sta funzionando alla perfezione dato che i politici stanno svuotando i granai riempiendoli di arsenali, con grande gioia e lucro della finanza non etica e di governi vari al suo servizio che fanno largo uso di quella che Fantuzzi, richiamando Orwell, considera le neolingua bellica.
L’autore ripone poca fiducia nella politica considerando le influenze di infinite lobby che vengono riportate come esempio al Parlamento europeo e che ovviamente contano molto più di qualsiasi popolo sovrano (di niente).
In questo quadro è interessante anche l’analisi della deriva digitale e dei social che sono considerati in maniera non troppo benevola di quella che viene chiamata la post democrazia.
«In definitiva la post democrazia si pone anche grazie al ruolo di amplificatore dei social, come volano di un capitalismo aggressivo, di un clima di paura e xenofobia di costante contrapposizione tra cittadini» scrive Fantuzzi. «La società dei social è, per sua stessa natura, polarizzata, creatrice di confusione e tende spontaneamente a non tollerare ciò che eccede dalla logica del like». «Ci siamo, esistiamo, abbiamo riconoscibilità se il social di turno lo conferma».
E in merito alla tragedia delle alluvioni in Romagna si esprime duramente sempre in merito ai social: «L’animale da social è colui o colei che non è più avvezzo al dolore, proprio e altrui, alla disgrazia, alla morte, ma ne discetta come la frequentasse abitualmente, dispensando di tutto». «Ci troviamo dunque al bar dei device, dove si consuma a dismisura, senza limiti e non si paga, se non quando si è offeso qualcuno oltre i limiti del Codice Civile; o meglio, si paga, fornendo gratuitamente i propri dati in pasto alle voraci piattaforme private».
«Siamo più social che sociali ma sopratutto soli nonostante la bulimica e a tratti disperata esposizione di momenti di socialità, cene, feste, vittorie sportive, ma anche di un dolore che forse resta la parte più autentica di questa tragica e sconclusionata finzione».
Per creare una perfetta società dell’emergenza c’è sempre bisogno di un nemico, vero presunto che sia, e se non c’è ovviamente lo si crea. Un nemico che oggi è nemico, domani amico, dopodomani nemico e così via. Un nemico quindi in perfetto stile orwelliano laddove appunto la storia e la cronaca vengono scritte da media e personaggi palesemente prezzolati dal potere economico o politico, che siano giornalisti, intellettuali, opinionisti, scienziati, presunti esperti e varia.
Fantuzzi per corroborare le sue tesi riporta molti passi di studiosi e intellettuali che confermano autorevolmente quanto lui afferma, fra i vari citiamo il sociologo Baumann, l’antropologo Mauro Van Aken, lo scrittore Marco Armiero, lo storico Franco Motta, lo psicologo Jonathan Haidt di cui su questo giornale abbiamo recensito il suo libro: La generazione ansiosa.
Interessante da parte dell’autore la citazione del disumanesimo che viene fatto risalire proprio all’inizio del tragico e famigerato periodo dei lockdown.
«Disumanesimo come sistema valoriale dove individualismo esasperato, isolamento, disprezzo dell’altro e delle sue opinioni sono la bussola, l’approdo naturale del bipolarismo che tutto semplifica e porta all’essenza del capitalismo liberista: un consumatore distanziato, non più una persona in connessione con il pianeta e gli altri ma con un dispositivo col quale crede di essere libero, autosufficiente e di poter fare ciò che desidera. Una finta libertà vincolata oltretutto alla disponibilità di risorse finanziarie e di una carta di credito o di strumenti di pagamento, con la quale il consumatore cede gratuitamente le proprie informazioni, le uniche che contino in un mondo dove ormai non siamo ciò che pensiamo ma ciò che consumiamo o che desideriamo acquistare».
Speriamo che dal disumanesimo si ritorni all’umanesimo, anche se piuttosto che ritornarci i miliardari padroni del mondo ci stanno costruendo un futuro da incubo transumano, che è come passare dalla padella alla brace.
Altra strada interessante indicata dall’autore è quella della prossimità, cioè delle relazioni vere e sane, non virtuali.
«Prossimità nelle relazioni, nel fare politica, nell’esercitare il potere, nel gestire l’economia e la finanza. Un utopia? Forse no, se partiamo dal presupposto che il valore dello scambio non possa più essere soltanto quello monetario, bensì della relazione. Da soli, distanziati, non siamo nulla, anche se ricchi di beni; non possiamo bastare a noi stessi. Siamo relazione, siamo connessione».
Infine Fantuzzi delinea la vera emergenza.
«Se un nemico esiste, è solo il capitalismo che genera le emergenze connaturate a un rapporto predatorio con la Terra. Un capitalismo che è in sé caos e crisi e senza di quelle mostra con evidenza i propri limiti, scaricandoli su di una umanità sempre più priva di fondamenta che non intravvede alternative all’individualismo e al profitto. E genera un uomo ormai simile agli stessi oggetti che egli stesso produce, una merce sul mercato di un lavoro incerto e precario, un corpo i cui pezzi, se si dispone di risorse economiche, possono essere sostituiti. Un uomo tuttavia irrimediabilmente sempre più solo e distanziato dietro ad un device, in guerra col mondo intero, moderno cacciatore di likes, armato di cellulare ma inerme al cospetto della vita. Forse l’emergenza più drammatica e profonda cui far fronte».
Parole che condividiamo e con le quali consigliamo la lettura del libro.
Foto: Markus Spiske per Pexels