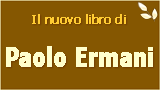Giornalista, scrittore, studioso, ricercatore, direttore editoriale, traduttore; schivo, lontanissimo dai riflettori, giustamente diffidente nei confronti di social e giornalismo mainstream, anticipatore di pensieri e analisi assai profonde e lungimiranti. Fermo nei suoi convincimenti a prescindere dalla follia moderna, anche quando tutto intorno si inabissa, così come è stato nel tragico periodo della faccenda Covid. Stiamo parlando di Valerio Pignatta.
Padre di quattro figli e punto di riferimento per centinaia di migliaia di persone che hanno letto i libri curati da lui, con un lavoro editoriale eccezionale e scrupoloso, ne citiamo alcuni tra i più importanti dei tanti:
The China Study, di T. Colin Campbell e Thomas M. Campbell II
Traumi e shock emotivi (Waking the tiger), di Peter A. Levine
Succhi freschi di frutta e verdura, di Norman Walker
Il metodo Ornish per curare le malattie cardiache, di Dean Ornish
La fine del diabete, di Joel Fuhrman
La prevenzione antinfettiva e oncologica, di Giuseppe Di Bella
Valerio, sfatiamo subito la credenza che chi ha figli non possa fare cambiamenti reali; tu che nei hai addirittura quattro e ci sei riuscito, quindi significa che si può fare?
«Si dice spesso che la morte è l’unica cosa certa. In realtà, come ci insegna il buddhismo, ce n’è un’altra di cosa certa ed è l’impermanenza. Ossia le cose cambiano sempre e continuamente anche se tu non vuoi. Niente rimane mai esattamente com’era. Per cui, siccome potrebbero cambiare non proprio come volevi, sarà meglio mettercisi in prima persona. Un po’ la spinta è partita da queste riflessioni e dai testi di filosofia orientale misti alla letteratura della beat generation. Io poi avevo molto da “cambiare”. Chi ha lavorato in fabbrica può benissimo capire quello che intendo. Di spinte al cambiamento ne hai a tonnellate. A ciò si aggiunga la condizione depressiva “Pianura Padana” che si riassume sinteticamente in “perbenismo, nebbia e zanzare” e che rappresenta un altro forte stimolo. Insomma ci vogliono serie motivazioni, sforzi reali e tanta determinazione ma difficilmente si può mancare il risultato sperato, perché comunque la vita viaggia già verso il cambiamento per suo conto come dicevamo prima, per cui cavalcando quello che arriva, essendo cioè attenti e aperti a cogliere le occasioni, ecco che si riesce a imbarcarsi in nuove situazioni. Io non ho particolari qualità operative o genialità. Può farcela chiunque a cambiare la propria situazione esistenziale se essa non lo soddisfa più. Certo non domani. Pazienza e costanza sono determinanti».
Sfatiamo un’altra credenza, addirittura più radicata, e cioè che un operaio (i detrattori di chi propone cambiamenti usano spesso questa categoria) non possa cambiare perché è “povero”, ha tante spese da pagare, ecc. Tu sei partito come operaio in età giovanissima e oltre a fare comunque cambiamenti profondi, poi ti sei pure laureato tre volte. Qual è stato il tuo cammino? E cosa diresti a chi pensa che se sei un operaio, o comunque se vieni dal “basso”, non puoi “cambiare”, perché l’unica cosa di cui ti devi occupare è portare a casa i soldi, non importa come?
«Sì, io ho lavorato per circa un decennio in fabbriche metalmeccaniche in cui per buona parte dell’anno entravi al mattino che era buio e uscivi la sera che lo era di nuovo, con nebbia aggiuntiva. Lavoro ripetitivo, molto rumoroso, privo della possibilità di esprimere una qualsivoglia specie di creatività. Non era il massimo. Mettersi a studiare a partire da questa situazione non posso dire che sia stato facile, per cui prima ho cercato alternative lavorative che mi lasciassero più tempo. Comunque credo di poter dire che in generale si possa fare. Anche perché i miei figli/e hanno poi fatto uguale, ossia si sono laureati/e lavorando (i primi tre e il quarto sta terminando). Di studenti lavoratori ne ho incontrati tanti. Ce ne sono molti di più di quello che si immagina e normalmente sono anche molto bravi e impegnati, proprio perché hanno piccoli inferni da cui fuggire oppure grandi sogni che vogliono realizzare. Sono status culturali/professionali a cui si può pervenire ma certo non con un click come siamo abituati a fare».
Sei una persona di grande professionalità, competenza e talento ma hai rifiutato incarichi prestigiosi che ti avrebbero portato in giro per l’Italia e per il mondo, per poter stare vicino alla famiglia e veder crescere i tuoi figli. Cosa daresti come consiglio a quelle persone che con la scusa di dover provvedere ai figli fanno lavori per cui poi i figli li vedono e seguono ben poco?
«Non sono in grado di valutare bene. Credo che ogni genitore agisca per il bene dei propri figli. Almeno è auspicabile che lo pensi e lo faccia. Le contraddizioni poi ci sono sempre. Come genitore pensavo fosse importante dare ai figli presenza, vicinanza e velocità di decondizionamento ogni qual volta tornavano dall’asilo, da scuola, dal lavoro ecc. con cognizioni indotte dal sistema di tipo omologante, razzistico, militarizzante, discriminante, fascistizzante, maschilizzante ecc. Se sei lì, a tavola a pranzare insieme, e senti il mare di stupidaggini che dal mondo i figli portano a casa e su cui relazionano, ti è più facile intervenire subito e proporre letture e visioni diverse che non approfittano delle giovani menti inesperte per indottrinarle. Questo è stato sicuramente bello. Ovviamente in primis viene l’affetto e la possibilità di stare insieme, di giocare, confrontarsi, lavorare nel podere, godersi insieme gli animali, il bosco ecc. Una volta una collega mi chiese di farle vedere le foto dei miei figli/e e rimase stupita dal fatto che non ne avessi con me, ma le spiegai che io ci vivevo con i miei figli e non avevo bisogno di vederli in fotografia. Non avevo quadretti sulla scrivania, ma li vedevo in originale. Questo per me è stato importante. È anche vero però che ora che sono grandi soffro per non aver accumulato il denaro sufficiente a dar loro una mano in modo consistente. Il mondo è diventato più complesso, i lavori che si trovano sono precari e spesso malpagati. Sono ragazzi/e che si impegnano molto, ma forse se avessi accettato lavori professionalmente più retribuiti, pur dovendo sparire da casa, ora avrei potuto aiutare i miei figli in maniera adeguata. Non so da che parte stia un giusto fare. Forse bisognerebbe chiederlo a loro».
Una persona come te con le tue conoscenze e preparazione avrebbe potuto lavorare ovunque e guadagnare moltissimo se si fosse fatto meno scrupoli morali, invece hai deciso di lavorare per chi aveva dei valori simili ai tuoi; perché lo hai fatto?
«Mah, lavorare ovunque non so. Ho lavorato per grandi marchi editoriali, questo sì, ma non è andata molto bene, nel senso che c’era poco feeling e anzi anche una certa censura latente sui lavori svolti. Nell’Italia berlusconiana poi era molto sentito un certo schierarsi e sappiamo bene che l’impero editoriale di Berlusconi invadeva ampi settori culturali, per cui mi sono sentito maggiormente attratto da quelle case editrici e riviste che veicolavano un mondo più umano, meno vincolato a denaro e successo o alla prostituzione fisico-mentale. Diffondere contenuti culturali pacifici, salutistici, spirituali migliorativi nonché tecniche agricole, dietetiche, terapeutiche per stare meglio in una società con molti infelici e persone in difficoltà o sofferenti, mi sembrava un modo di dare un contributo significativo all’esistere; perlomeno per quanto riguarda la mia di esistenza e spero lo sia stato davvero anche per altri/e. Oggi credo tuttavia che le differenze tra i vari progetti culturali editoriali sia spesso solo di facciata e che il capitalismo tecnoscientifico imperante si sia ingoiato tutto, anche le visioni utopiche e gli intenti sinceri di “cambiare il mondo” di qualche decennio fa. Un nuovo slancio potrebbe venire solo da una fase critica seria che potrebbe innescare una prassi rivoluzionaria consistente la quale cancellerebbe alla base una serie di capisaldi economici e politici che ci imprigionano. In questo senso i periodi (terribili) che viviamo sono comunque interessanti».
Perché hai scelto di trattare i temi della salute e dell’alimentazione visti da un piano diverso da quello tradizionale?
«Per quello che ho visto sin da giovane, medicina e alimentazione convenzionali hanno senz’altro dei pregi ma anche grossi limiti. La medicina ufficiale se da un lato consente di intervenire con efficacia e rapidità sulle urgenze come incidenti, infarti, tumori invasivi, infezioni batteriche ecc., sulle patologie croniche spesso ha ben poco da dire. Sappiamo poi che essa affronta specialmente i sintomi e non la malattia alla radice e considera il singolo organo invece che l’insieme dell’essere umano comprensivo di corpo intero, mente e spirito. Ciò porta anche la classe medica ad avere talvolta un comportamento poco umano rispetto ai propri pazienti, che si sentono più oggetti che non persone bisognose di cure e affetto da parte dei loro terapeuti a cui stanno chiedendo aiuto. Le medicine non convenzionali, alcuni decenni fa, sembravano offrire un’attenzione diversa per il paziente, andavano alla ricerca delle cause alla base di una malattia e non si fermavano ai sintomi; inoltre utilizzavano rimedi naturali con pochi o nulli effetti collaterali, al contrario dei farmaci di sintesi che ne hanno parecchi. Oggi però non sono più tanto sicuro che sia ancora così, perché sono cambiate molte cose. Oggi si può assistere a un uso delle medicine complementari in chiave sintomatologica e non olistica, i comportamenti dei medici verso il paziente non sono sempre così empatici e la legge del denaro fa la sua parte. Infine, negli ultimi anni non possiamo certo dire che, salvo eccezioni, i medici, convenzionali e non, abbiano dimostrato e difeso la loro indipendenza di pensiero e neanche il dettato deontologico. Per le diete il discorso è più o meno simile, senza contare che l’industria alimentare, gli stili di vita velocizzati e la polverizzazione delle esistenze su più luoghi e tempi fanno il resto. Mantenere un’alimentazione sana con certe modalità di vita è praticamente impossibile. L’alimentazione naturale passa prima da un cambiamento dello stile di vita. È un discorso lungo».
Cosa consiglieresti a chi si vuole approcciare a un'alimentazione sana e a curarsi in maniera più naturale possibile e meno invasiva?
«La prima cosa importante che mi sembra di aver compreso è che, in ogni caso, rigidità e aspettative di vita eterna vanno abbandonate. Ovvero, non è che se mangio naturale, mi curo con le medicine naturali e sto attento a qualsiasi terrorismo dietetico o ambientale mi salverò necessariamente. La vita è molto più complessa e le interrelazioni con il mondo che ci circonda sono più di quelle che immaginiamo o che siamo in grado di avere sotto controllo. Basti pensare a tutte le sostanze tossiche che ingeriamo mangiando, respirando, toccando o bevendo (nanoplastica, PFAS, pesticidi, cosmetici chimici, inquinanti aerei, particolato ecc.). Delineato un limite, va detto ovviamente che abbiamo comunque tanta possibilità di manovra per cui possiamo fare scelte oculate che ci possono portare a vivere nell’immediato a un livello superiore di serenità e salute, per noi e per il pianeta. I testi di medicina non convenzionale e di alimentazione naturale sul mercato sono ormai tantissimi. Certo, molti sono carta stampata e non libri, ma con una certa dedizione e chiedendo consigli si può arrivare in un certo tempo a capire quali sono i manuali seri e farne tesoro. Di medici olistici e biologi nutrizionisti poi è zeppo il mondo per cui si tratta solo di sborsare, provando e sperimentando. Qui in effetti sta il problema; la vile pecunia. Chi può oggi permettersi di curarsi privatamente o di spendere capitali per integratori e medicine naturali? Ci sono progetti che cercano di risolvere questa problematica e ci sono anche piccoli trucchi da mettere in moto, ma il discorso qui si farebbe molto lungo. Comunque in un certo modo si può fare. Anticipando un po’ le cose diciamo che la base è dove vivi, che lavoro fai, che relazioni hai e quanta sobrietà sei in grado di digerire».
Cosa pensi dei social e dell’intelligenza artificiale?
«A dire il vero, per quanto possa sembrare strano, non ho ben presente cosa sia o faccia un social. Io uso Telegram sul computer, per scambiare messaggi. Certo, ho visto schermate di Facebook ma non vado oltre. Visto che i miei figli/e non hanno/seguono social e sono giovani, penso si possa vivere anche senza e sicuramente meglio. Forse LinkedIn può essere utile per il mondo del lavoro. Altro non saprei. Come la TV del resto. In casa nostra non è mai entrata. Ma non ci manca. Sono dinosauri estinti che non hanno mai fatto parte della nostra vita. A voi manca un tirannosauro? Mi rendo conto che, passi per la TV, ma dire che un social è un dinosauro estinto può sembrare un’eresia. Eppure mi sto convincendo sempre più che si stiano estinguendo. La consapevolezza della loro natura intrinsecamente malvagia, autoritaria e centralizzante si sta diffondendo velocemente. E non è il caso di impegnarsi per salvare questa specie. Sull’intelligenza artificiale (IA) invece tocchi un tasto dolente. Questa la conosco bene eccome visto che sta togliendo lavoro a me e a tanti altri come me che lavorano nell’industria culturale e non solo. Le implicazioni dell’IA sono però molte altre. Non si tratta solo di lavoro rubato. A quelli che dicono che la tecnologia è neutra e che dipende dall’uso che si fa di uno strumento tecnologico suggerirei di leggere il libro di Jacques Ellul, Il sistema tecnico, analisi in gran parte ancora insuperata. L’IA potrebbe rimpicciolire alquanto la nostra libertà personale e disintegrare la nostra realtà in un mondo di facezie più o meno reali contenute in una scatola informatica al di fuori della quale non c’è più nulla. Neanche l’odiato Google odierno, che a quel punto ci sembrerebbe così simpatico. Poter comunicare, ricercare, scambiare, lavorare, partecipare alla società, informarsi ecc. tutto solo e all’interno di una scatola IA è molto pericoloso. Bisognerebbe almeno battersi affinché chi vorrà entri pure nella scatola i cui padroni gestiranno il suo esistere, ma per chi non vorrà deve rimanere la possibilità di starne fuori. Questo è l’obiettivo minimo. Il massimo sarebbe molto semplice, ossia staccare le spine a questi superelaboratori e software. Un atto che può fare anche un bambino e se nessuno lo fa domandiamoci a chi giova. A voi mancava l’IA? Era un mondo peggiore senza? Una società con dei tabù è sbagliata? Gli Amish, che di tecnologia se ne intendono, fanno notare che la questione base è la differenza tra strumento tecnologico e macchina automatica. Lo strumento tecnologico – come una penna a sfera, un martello ecc. – è appunto uno strumento che tu puoi usare in indipendenza. Una macchina automatica invece non puoi gestirla o manovrarla tu, ma la subisci. Ad esempio la televisione. Quindi può asservirti. L’IA secondo voi in che categoria rientra? Sarebbe bello discuterne».
Hai letto una quantità enorme di libri; se ne dovessi consigliare cinque, quali sceglieresti?
«È davvero difficile per me fare una scelta di questo tipo. Nell’immediato non so bene cosa e quando ha segnato una svolta nella mia consapevolezza o crescita personale. Ricordo alcuni testi come opere che mi avevano colpito e che poi ho sempre avuto presente, ma credo che negli anni si sia tutto sovrapposto e che le letture assimilate si siano mischiate a volte in un groviglio inestricabile. Comunque, in modo grezzo potrei citare:
Thoreau, H.D., Walden ovvero vita nei boschi
Pirsig, R., Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta (l’unico libro che in vita mia ho letto due volte)
L. Tolstoj, Il Regno di Dio è in voi
Senzaki, N. e Reps, P. (a cura di), 101 storie zen
Vaneigem, R., Il movimento del libero spirito
Hai sempre avuto un grande interesse per le religioni e ne hai scritto anche due libri; ci vuoi spiegare perché?
«A tutti sarà capitato di domandarsi prima o poi qual è il senso dell’esistere, se esiste un altro mondo oltre la vita terrena, se c’è un Dio, se c’è una speranza di giustizia e di fine della povertà e della miseria su questa terra ecc. In teoria, la spiritualità (e nello specifico le religioni, da cui però è distinta) dovrebbe avere le risposte o perlomeno aiutare a porsele. Nel fenomeno religioso mi sono interessato di quei gruppi o personaggi che hanno privilegiato nel dialogo spirituale con Dio una richiesta di giustizia terrena per gli svantaggiati e i sofferenti. Alla fin fine non so se un Dio ci sia davvero o no, se oltre la vita ci siano “eventi” interessanti o meno, ma sicuramente ho verificato che esiste la possibilità di una vita spirituale, o morale che dir si voglia, autentica, che aiuta a evolvere personalmente, favorendo allo stesso tempo la vita degli altri anche se non si è credenti così come questi vengono definiti oggi. Credo cioè che nelle religioni ci siano aspetti buoni che si possono recuperare, estraendoli però da quei contenitori autoritari e irregimentati per trasportarli in una visione spirituale più ampia post-teistica e post-religionale. I due libri che ho scritto vanno in questo senso».
Quali personaggi o movimenti nella storia ti hanno influenzato di più nel tuo cammino spirituale e perché?
«Credo che potrei citare i saggi politici di Tolstoj, i testi classici dell’anarchismo (Bakunin, Kropotkin ecc. ma anche Bookchin), i testi base del movimento della decrescita (Latouche, Ellul, Charbonneau ecc.), i testi classici della spiritualità orientale come il Tao te ching, il Dhammapada, i libri di Jiddu Krishnamurti, il post-teismo, i testi storici sul libero spirito e l’anabattismo e movimenti derivati fino a quelli odierni. In medicina i testi di Ivan Illich e di Thomas Szasz. In filosofia/teologia Nietzsche, Spinoza, Buber, Panikkar, ma anche Byung-Chul Han. E tanta tanta letteratura».
Vista la situazione mondiale, dal punto di vista spirituale, pensi che l’umanità ce la possa fare a migliorare?
«Penso che per la maggior parte delle persone sia ormai chiaro che sono tempi in cui l’oscurità avanza. È una cappa che prova ad avvolgere tutto, che vorrebbe indurre a chinare la testa e a obbedire ai vari governanti e potenti della terra che in realtà sono individui vomitati da chissà quale inferno dove non ce li volevano e hanno fatto di tutto per appiopparli a noi. Spero che in caso di guerra/e allargata/e il “popolo bue” questa volta disobbedisca e non si faccia prendere dalla cieca obbedienza, dalla paura di ritorsioni o dal bieco nazionalismo patriottico. Spero anche che si diffonda la consapevolezza che il problema non è riconoscere stati nuovi o nuovi confini, ma che sono i confini stessi a costituirlo e quindi che forse i soggetti primari da abolire sono proprio gli Stati e i cumuli orgiastici di Stati come la UE, depravazione della vita politica ed economica come mai. Detto questo, è anche vero che lo spirito umano di giustizia cova sul fondo di ogni essere, per cui non si può sapere se e quando riemergerà in maniera decisa ribellandosi ai diktat di una classe politica corrotta ed egoica a livelli colossali. La storia ci ha dato esempi notevoli in questo senso per cui non lo escluderei. Senz’altro il fattore tempo è cruciale, in quanto se parte un conflitto atomico la presa di coscienza tardiva non salva un bel niente. Leggendo i giornali e ascoltando i notiziari e poi guardando intorno a me la vita delle persone, ma anche la mia peronale, ho pensato che ci stiamo comportando proprio come nei film apocalittici come The Day After. In quei film lo spettatore è indirizzato dalla sceneggiatura e dal regista e cogliere la discrepanza tra gli eventi che precipitano verso il baratro e la vita quotidiana delle persone che continuano la loro imperterrita lotta per le miserie di tutti i giorni: carriera, invidia, rivalità, consumo, soldi ecc. Quando vidi il film a suo tempo pensai che non sarebbe mai potuto accadere qualcosa di simile perché quello era un film mentre nella realtà ci si sarebbe mossi in massa di fronte a un pericolo simile. E invece no, tanto di cappello a regista e sceneggiatore. Stiamo facendo esattamente quello, continuiamo a vivere come se nulla fosse invece di togliere dalle mani dei bimbi capricciosi che ci guidano le chiavi della macchina, dato che potrebbero farsi e fare del male poiché non hanno la statura morale per capire cosa stanno facendo. Per favore, non votate più».
Alcuni dei testi pubblicati da Valerio Pignatta:
L’insostenibile leggerezza dell’avere, EMI
Pensare come le montagne, Terra Nuova (con Paolo Ermani)
L’ABC della medicina naturale, Macro Edizioni
Dio l’anarchico. Movimenti rivoluzionari religiosi nell’Inghilterra del Seicento, Arcipelago Edizioni (IULM)
Storia delle eresie libertarie, Odoya
Alcuni testi tradotti:
Mbembe, Achille, Brutalismo, Marietti 1820
Mbembe, Achille, La comunità della terra, Marietti 1820
Grondin, Jean, Lo spirito dell’educazione, Queriniana
Vogels, Walter, Levitico. Celebrazione e santità, Queriniana
Chi volesse contattare Valerio Pignatta può farlo alla seguente mail: info@paea.it e sarete ricontattati.